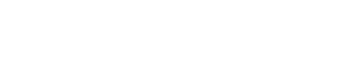Il pianista
Il pianista di Roman Polanski è un film crudele e al tempo stesso discreto, perché racconta con magistrale sobrietà la storia di un uomo semplice che, suo malgrado, si ritrova ad inseguire la propria sopravvivenza nella Varsavia della Seconda Guerra Mondiale.Tratto dall’autobiografia di Wladyslaw Szpilman, famoso ed apprezzato pianista ebreo che trasmetteva ogni giorno da Radio Varsavia, il film parla dell’odissea di persecuzione di un uomo onesto e concreto, ma non di un eroe. Szpilman è, infatti, un uomo che sa distinguere il bene dal male e che non scende mai a compromessi, ma che al tempo stesso non si espone in prima persona in una situazione che avverte essere molto più grande di lui.
E’ proprio questo suo defilarsi dal mondo e dalla storia ad attraversare interamente il film ed a costituire la chiave di lettura di una narrazione che è essenzialmente visiva.
Ogni avvenimento importante, dalle prime incursioni naziste, alla resistenza degli ebrei del ghetto ed arrivando fino alla liberazione di Varsavia, viene raccontato privilegiando un’inquadratura costante, dall’alto, spesso laterale e per nulla efficace rispetto alle pure esigenze narrative.
Ma la scelta non è casuale e la prospettiva è proprio quella del protagonista che osserva ogni cosa da una finestra, con le luci spente, oppure dietro le tende, o nascosto di lato, per non farsi notare, perché nessuno lo veda. Perché sia solo lui ad osservare gli altri, ma non gli altri ad osservare lui.
Non è questa solo un’opzione dal semplice impatto drammatico, ma soprattutto un espediente narrativo di notevole rilevanza, perché intende esprimere il disagio di un uomo che, nonostante tutto, non riesce a vivere totalmente all’interno alla storia e che, al tempo stesso, non può evitare di esserne coinvolto.
Il film comincia proprio con una scena in cui, sotto i primi bombardamenti del ‘39, Szpilman cerca a tutti i costi di portare a termine la sua esecuzione di Chopin in diretta alla radio, e non tanto per inseguire qualche vacuo luogo comune intorno alla necessità di “continuare lo spettacolo”, quanto perché convinto del fatto che la propria esistenza sia qualcosa d’altro rispetto alla storia, tale per cui, se non può percorrere una strada del tutto separata, ne potrà forse condurre una per lo meno parallela. Da qui il film si avventura a raccontare non solo gli eventi della città di Varsavia tra il ’39 e il ’45, ma anche, in questi stessi anni, il percorso di un uomo che si rende conto, suo malgrado, di quanto sia impossibile rimanere fuori dal gioco.
La presa di coscienza sarà amara e non si risolverà in un vero e proprio lieto fine. Szpilman tenterà, in alcuni casi, di conquistare un suo posto, di esercitare un ruolo nel dramma della guerra, ad esempio chiedendo di entrare a far parte di un’organizzazione sovversiva che cominciava ad agire a Varsavia, ma inutilmente, perché troppo conosciuto dall’intera cittadinzanza per passare inosservato.
Riuscirà invece a trovare aiuto da diverse persone che lo copriranno, lo ospiteranno, lo cureranno: si renderà conto che molti lo amamo e lo rispettano e non sarà quindi un grosso problema per lui trovare asilo ed assistenza, ma più difficile sarà riuscire a trovare il modo per restituire a sua volta questo appoggio.
Con il passare dei mesi e degli anni, crescerà in lui la chiara consapevolezza che, di là dalla finestra, sono rimaste persone che lottano per le strade per la loro e la sua libertà, persone alle quali lui non riesce a portare aiuto ed il senso di esclusione e di inutilità si farà sempre più pressante.
Non è, tuttavia, un film che sembra condannare quest’uomo.
E’ un film che cerca di raccontare la storia di una persona che non è stata un eroe, e neppure una totale vittima, perché nonostante le persecuzioni, la sofferenza, la paura, la fame e la malattia, non ha conosciuto i campi di concentramento, né tanto meno la morte come il resto della sua famiglia.
E’ la storia di un uomo che, seppur con le migliori intenzioni, si sente inadeguato rispetto al mondo e alla storia e non trova il suo posto, non trovando lo spunto o l’energia, per rappresentare, in qualche modo, la differenza; un uomo che si vede, invece, costretto a rifugiarsi, per non essere catturato, e che trova consolazione solo nella musica, o nel ricordo e nella fantasia di essa.
L’unica sequenza, verso la fine del film, in cui la cinepresa si alza e comprende nella medesima scena sia la città che Szpilman, è quella in cui, durante la sua fuga, egli scavalca un muretto ed all’improvviso si trova difronte alla più totale devastazione, ad una Varsavia completamente rasa al suolo, luogo solo di macerie.
E’ una scena in cui sembra che, improvvisamente, il pianista rientri a far parte del mondo e della sua drammaticità, lui che non si era reso conto, che non aveva visto, chiuso e nascosto com’era stato per lunghi mesi.
Il contrasto, visivo in prima istanza, tra la sua fuga rappresentata da tutte le riprese in interno, spesso buie ed anguste, e la vastità di questa scena in esterno, in cui Szpilman esce allo scoperto e ritorna al mondo, dentro al mondo, sembra riassumere tutto lo spirito del film.
La storia si conclude con Szpilman che, terminata la guerra, riprende a Radio Varsavia l’esecuzione di quel notturno di Chopin che aveva interrotto nel ‘39: l’uomo ed il pianista sono tornati alla loro vita, quindi alla musica, unica grande consolazione e rifugio che Szpilman aveva trovato, in quei lunghi anni, alla disperazione e alla follia.